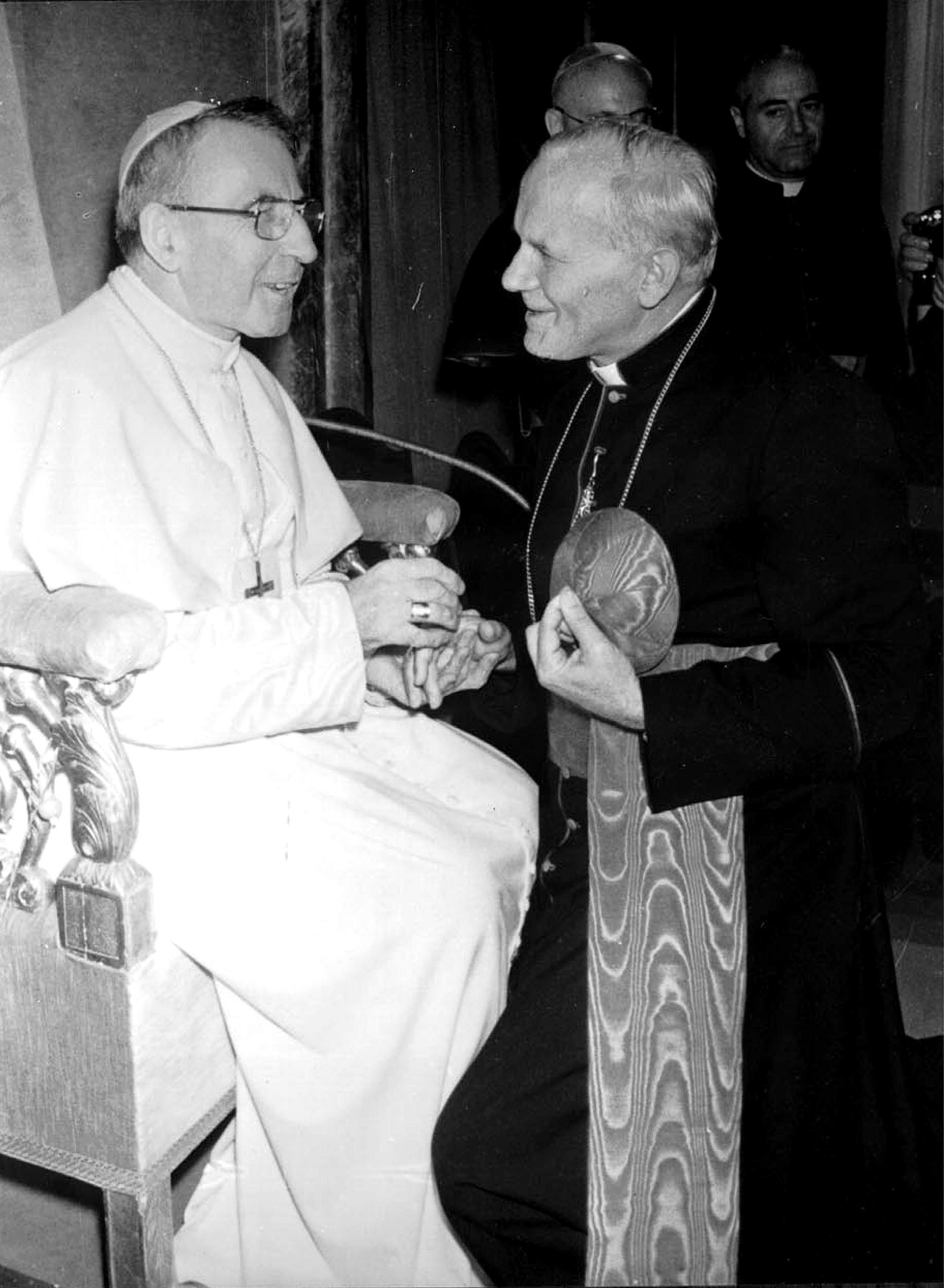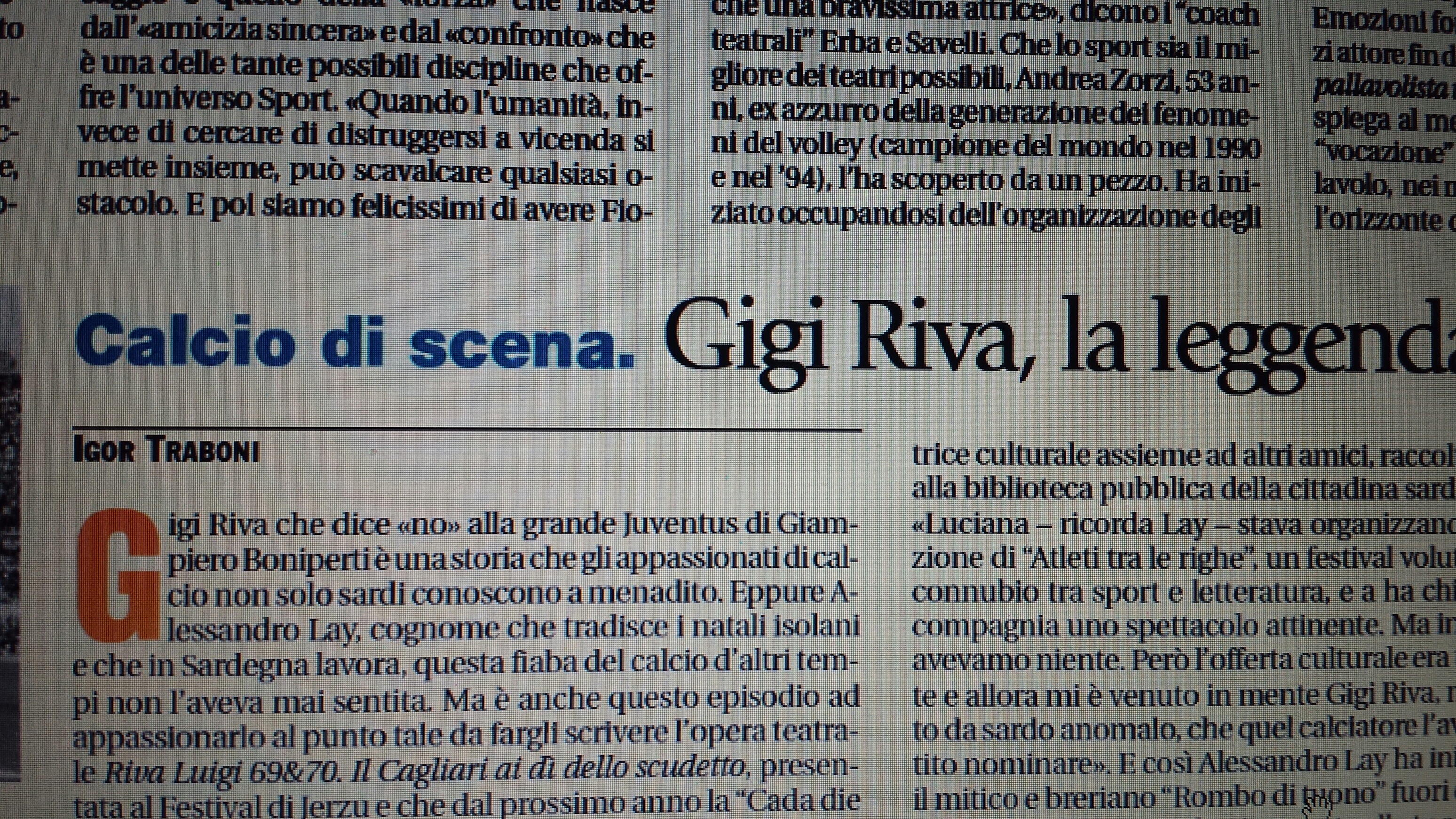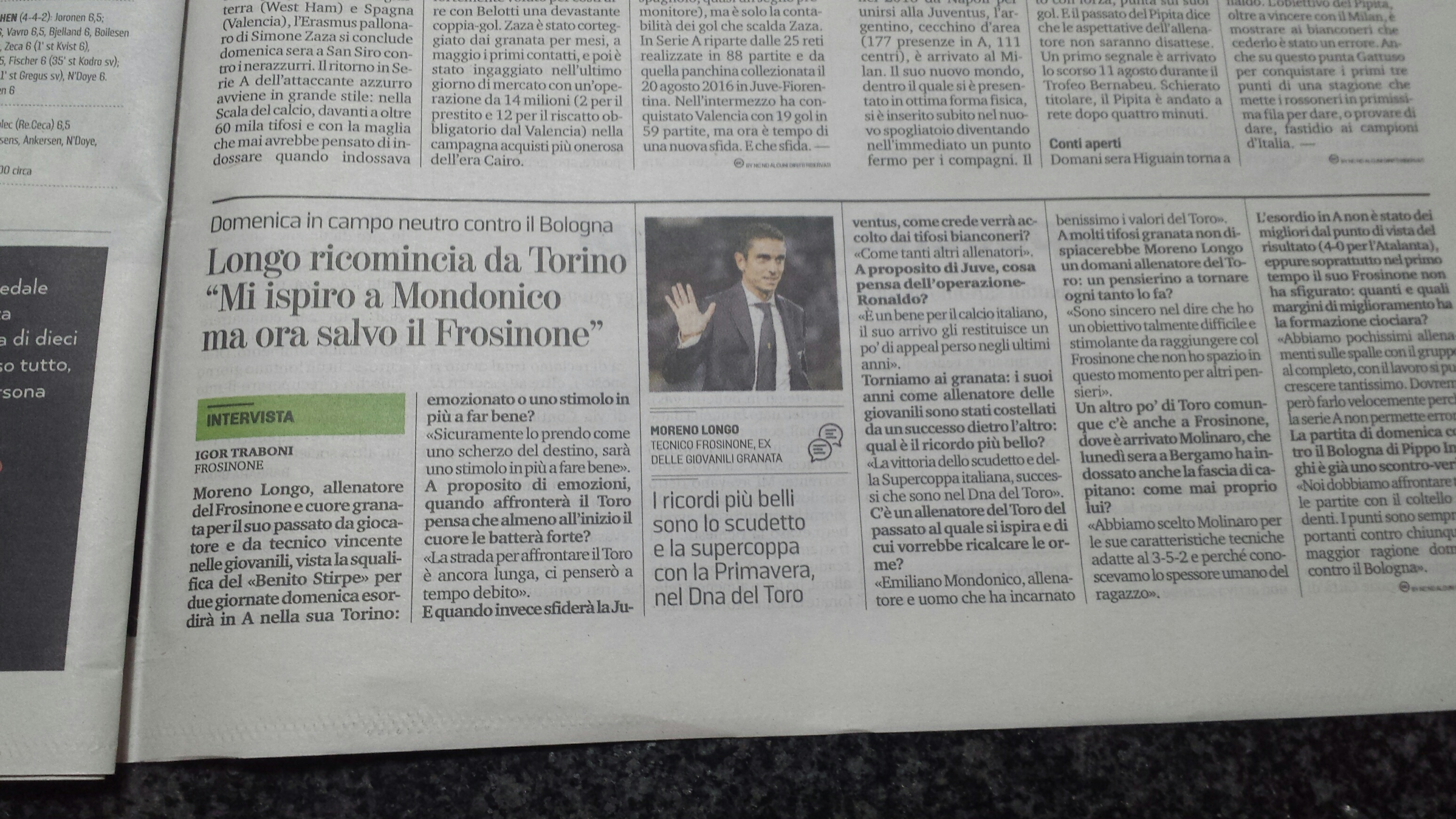Le penne islandesi hanno sempre ragione: prendiamo “Hotel Silence”, l’ultimo libro – almeno tra quelli pubblicati in Italia – di Audur Ava Olafsdottir, docente universitaria sessantenne, ritenuta la più grande scrittrice islandese vivente (se andiamo a comprendere anche i maschietti, però, Helgason Hallgrimur credo sia una spanna sopra).
Questo romanzo – che si può leggere anche come una serie di deliziosi racconti uno dietro l’altro – è la storia di Jonas, 49enne (che bella anche questa scelta di fermarsi alla soglia del mezzo secolo di età) che decide di andare lontano, in un posto dove c’è stata la guerra – e quale sia quel posto la scrittrice non lo dice mai – per fare la pace, soprattutto con sé stesso. In realtà, Jonas è laggiù che vorrebbe trovare la morte, lontano dalla ex moglie, da una figlia che ama più di ogni altra cosa anche se ha scoperto che non è sua figlia naturale, da una madre un po’ ingombrante come le sue parole e tesi svampite. Ma la morte non la trova (non riesce a darsela) dopo che ha conosciuto gli strani e intensi personaggi dell’Hotel Silence: poche camere d’albergo messe su alla meglio dopo che la guerra è finita e dove Jonas si ritrova insieme ai due giovani gestori e ai primi altri due turisti, in verità una attrice di fama che vorrebbe realizzare un documentario sul post guerra e un predone di opere d’arte. Jonas nella sua piccola valigia riempita in Islanda mette dentro anche un trapano e qualche rotolo di nastro adesivo. Sono i due elementi indispensabili per iniziare lì una ricostruzione (le tubature dell’hotel, le porte di un piccolo ristorante dove è l’unico avventore, le camere di una casa dove alcune donne violate dai soldati hanno deciso di andare a vivere assieme): dalla ricostruzione materiale di piccoli grandi cose, alla ricostruzione di sé stesso, ma anche della giovane che gestisce l’hotel e di suo figlio piccolo. Sono pagine di una tenerezza unica, di una scrittura indissolubilmente legata alle atmosfere d’Islanda, anche a migliaia di km di distanza da una nazione che non ha neppure un esercito. Molto contribuisce alla buona lettura l’ottima traduzione di Stefano Rosatti e merito anche alla Einaudi che continua a pubblicare tutti i libri della Olafsdottir.
Pagine che profumano di una religiosità intensa, una sorta di bisogno disperato di Dio, di un Cielo meno cupo. Come peraltro già accadeva ne<Il rosso vivo del rabarbaro>, il libro della scrittrice islandese precedente a questo. Lì c’è Nina che non vuole sprecare le parole: <Quante particelle grammaticali ha adoperato Gesù Cristo per salvare il mondo? Pochissime>. Lì, in quelle stesse pagine, c’è l’essenzialità della terra d’Islanda: <Lo so che vorresti poter correre – dice la protagonista a una bambina che non può farlo per un handicap fisico – ma, guarda, c’è pieno così di gente che corre tutta la vita e non arriva mai da nessuna parte>.
Ecco, quella d’Islanda è una religiosità “familiare”, in una terra per niente facile, dove anche il Cristianesimo ha attecchito poco (qualche mese fa ne ho scritto sul settimanale “Credere”, intervistando i padri di una delle poche comunità religiose cattoliche presenti in Islanda). E dove le parole davvero restano scolpite come pietre. Grazie anche a libri come questo.
Ps: poi c’è l’Islanda delle mille atmosfere che si può scoprire grazie a scrittori italiani e libri meritevoli. Suggerisco “Siamo state a Kirkjubæjarklaustu, di Valeria Viganò (Neri Pozza), “Tutta la solitudine che meritate” di Claudio Giunta e Giovanna Silva (Quodlibet) e “Ghiaccio fuoco” di Nicola Lecca e Laura Pariani (Marsilio).