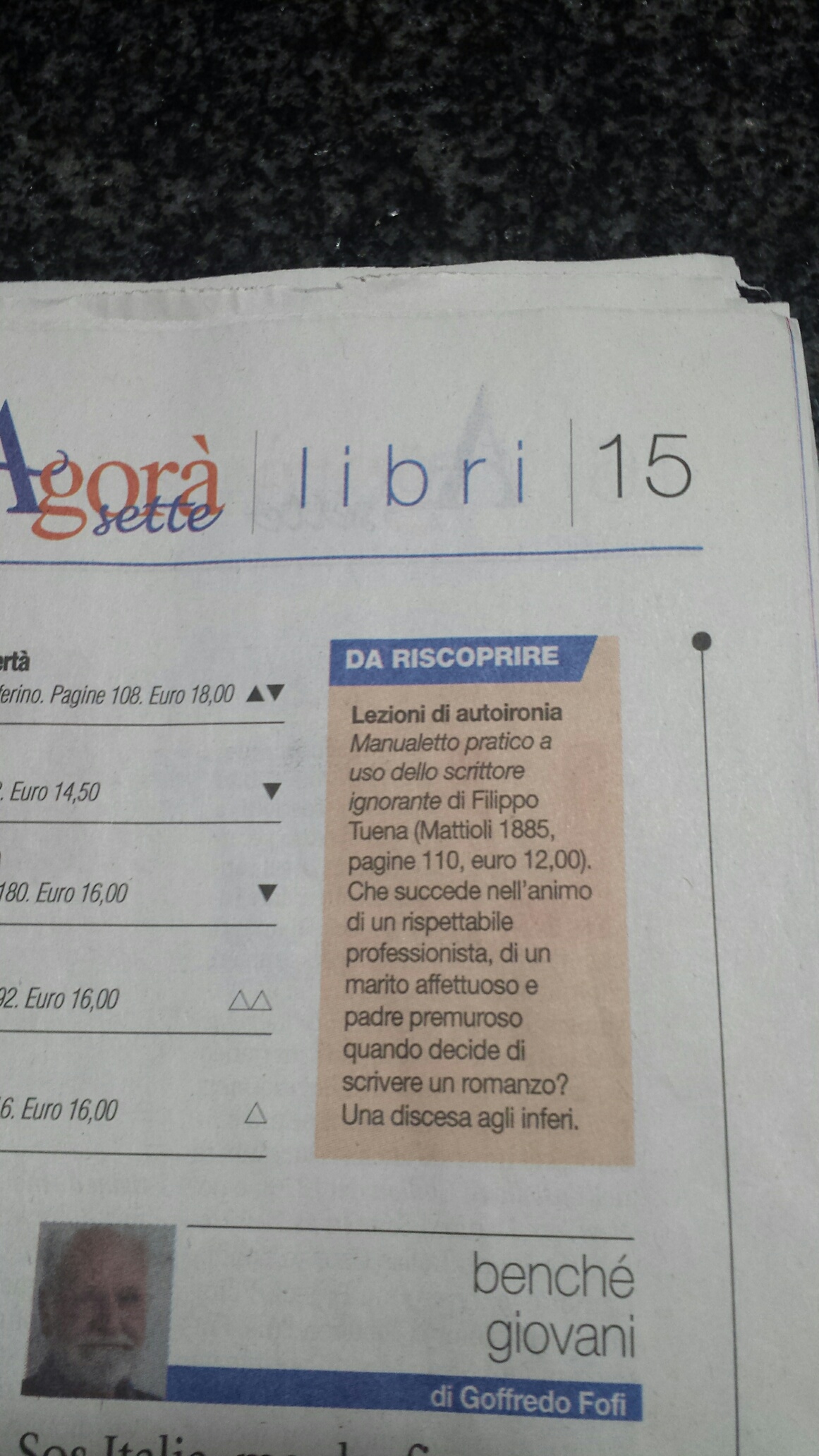I miei famosi trentatré lettori ( ma soprattutto i tanti amici comuni e i tantissimi che condividono la passione per il calcio) sanno che non ho in particolare simpatia (eufemismo) la Juventus.
Stesso discorso vale per il Napoli, e qui stanno in piedi anche motivazioni personal-familiari attorno alle quali non vale la pena discettare. Pur riconoscendo che ho adorato giocatori dell’una e dell’altra (Scirea e l’immenso Baggio Roby da una parte, dall’altra Rudi Krol e il mio conterraneo Peppe Incocciati), se avessi la sfera magica del calcio, vorrei che vincessero una partita sì e 30 no.
Non metto le mano avanti, e neppure le gambe in un pericoloso tackle, per dire invece che un libricino (nella migliore accezione del termine) di recente pubblicazione mi ha un po’ ravvicinato a Juve e Napoli, anzi a <Juve-Napoli. Romanzo popolare>, come nel titolo di questo libro di Darwin Pastorin e Vincenzo Imperatore, edito da Aliberti.
Vincenzo Imperatore (della cui amicizia seppur virtuale mi onoro, e spero che questo non mi faccia velo nel parlare di codesto libro) è il tifoso napoletano, ha scritto saggi economici-finanziari soprattutto sul (pessimo) ruolo delle banche, portando anche a teatro, in un’operazione coraggiosa come poche altre, uno dei suo libri.
Darwin Pastorin, brasiliano di nascita e italo-juventino per tutto il resto, è giornalista che chi dà mostra di seguire il football non può non conoscere (qualunque figlio che non mastica di calcio, tipo il mio che pure ho cercato invano di introdurre ai piaceri della pelota, si innamorerebbe degli eroi in mutande leggendo “Lettera a mio figlio sul calcio” pubblicato qualche annetto fa da Mondadori).
Il libro è un lungo derby a distanza “giocato” sul filo della “memoria”, quel termine magico che rende ancora più bello il calcio: ecco dunque un bel campionato di ricordi – come Pastorin e Imperatore scrivono nell’introduzione non a caso intitolata “precampionato” – che rende evidente perché si diventa tifosi di una squadra. E cosa questo significa nei secoli dei secoli.
A me in particolare sono piaciuti i capitoletti “vivere lo stadio”. Un po’ perché io sono cresciuto a pane e Matusa (il vecchio, in tutti sensi, stadio di Frosinone) e ora mi coccolo il bellissimo “Benito Stirpe”. Un po’ perché da mia nonna sentivo raccontare e mi affascinavano le storie di mio nonno maresciallo, che non ho mai conosciuto, che prestava servizio nella zona del vecchio stadio del Vomero e di come ogni mattina si alzassero spalancando le finestre proprio su quel prato di calciatori.
E se di calcio non capite un accidenti – cosa che in realtà spesso accade anche a chi di calcio afferma di capire – niente paura: questo libro è uno spaccato anche su tutto il resto che è poi la Vita (e dunque ancora il Calcio, ma qui il discorso si farebbe lungo…) e che due penne così sanno dipingere come un acquerello. Con 14 euro, insomma, vi portate a casa calcio e dintorni, senza pentirvene.